
Tu sei qui
La gelosia delle lingue
Che cosa accade in un autore quando decide di abbandonare la sua lingua per scrivere in una diversa dalla propria? Che cosa si perde in questo passaggio e che cosa si acquista? E poi, perché si lascia una lingua per adottarne un’altra? Sono alcune delle domande sulle quali cerca d’interrogarsi questo libro. Passare da una lingua a un’altra significa porsi di fronte a un rischio. Non si tratta di avere più o meno dimestichezza quanto essere nella lingua, imparare a osservare e a interpretare il mondo alla luce di una nuova esperienza. Questo fatto presuppone comunque una rinascita.
La scuola salvata dai bambini. Viaggio nelle classi senza confine
Un libro appassionato e incoraggiante che racconta con precisione giornalistica senza tuttavia perdere in coinvolgimento e empatia tante piccole e grandi scuole pubbliche italiane che si sono dovute ripensare per accogliere i nuovi studenti arrivati e ancora in arrivo da ovunque.
Adua
Adua, ultimo romanzo di Igiaba Scego edito da Giunti, è una storia a due voci: quella di un padre, Zoppe, e quella di una figlia, Adua, che presta il nome al titolo. Entrambi nati a Mogadiscio, condividono con l’autrice le origini africane. L’incipit del romanzo vede la protagonista chiacchierare con l’elefantino dalle grandi orecchie di piazza Santa Maria sopra Minerva a Roma. La donna riporta alla memoria tutta una vita, con un continuo movimento che procede in avanti e torna indietro, riscrivendo vicende che, nel ricordo, ogni volta, assumono un significato diverso.
Rwanda. La notte delle stelle cadute
È un libro breve, 87 pagine con l'indice, un punto di vista poco importante, quello di un bambino, un angolo marginale di una città, Kigali, che non si saprebbe indicare sulla carta, persa in un paese, il Rwanda, di cui conosciamo il nome solo per i massacri che vi sono avvenuti, in un continente immenso e differenziato che nominiamo con ignoranza al singolare, l'Africa. In queste poche pagine l'autore ci dà molto, ricrea situazioni e ambiente a partire dal piccolo Clement e dai suoi rapporti con la zia e con il vecchio Emanuel.
La zingarata della verginella di via Ormea
Amara Lakhous torna in libreria con un avvincente romanzo giallo. L’autore porta nel titolo una verginella e via Ormea. Tra questi due elementi è racchiusa l’intera vicenda. Fa da sfondo la Torino dei giorni nostri dentro la quale si muove una famiglia medio borghese con la sua verginella di quindici anni, un cugino nero, una nonna matriarca e tutti gli abitanti di questa famigerata via Ormea. Una tragedia colpisce la più conservatrice di tutte le famiglie torinesi: Virginia, rigorosamente vergine anche nel nome, viene stuprata proprio nella via in cui abita. Nulla sarà più come prima.
Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di loro
Si tratta di un racconto autobiografico, che mette a nudo la tragedia familiare dell'autore e insieme dà conto della realtà libica, passata e recente, della situazione geopolitica, con le manovre egiziane e quelle della Gran Bretagna di Blair, risalendo nella storia fino alla violenta occupazione italiana.
Il ministero del dolore
Dubravka Ugresić racconta la condizione di chi è straniero e in Jugoslavia e in Olanda. L'esilio di chi viene dalla ex Jugoslavia è particolare, che sia voluto, scelto o coatto, ha un peso in più rispetto all'esilio di altri, è ancora peggio del senso di sradicamento, nostalgia, solitudine che chiunque prova lontano dalla terra in cui è nato. Per chi viene da un mondo che si è dissolto in una guerra fratricida c'è, in aggiunta, la difficoltà e il dolore di ricostruire una identità andata in pezzi già nel suo paese, frantumata, a partire dalla lingua stessa, violentata e scissa.
Balkan pin-up
Dice bene la biografia di Veličković che si legge nella quarta di Balkan pin-up: «Una delle voci più coraggiose dell’élite intellettuale serba».






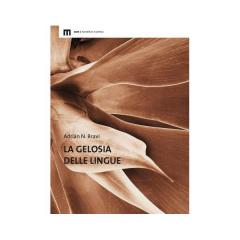
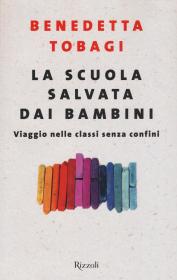
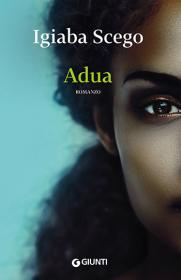
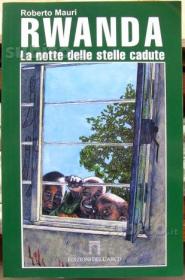
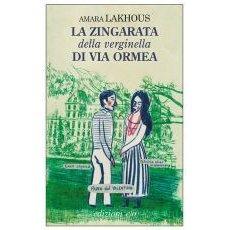


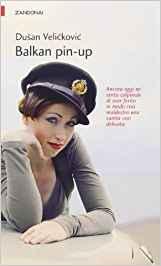
 © Il Gioco degli Specchi APS |
© Il Gioco degli Specchi APS |